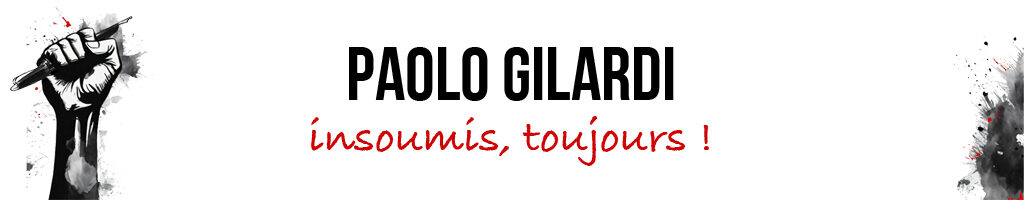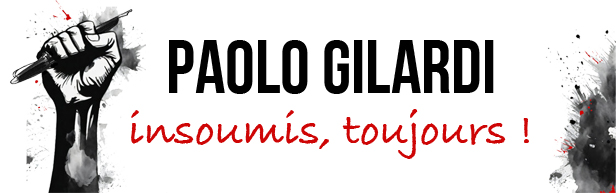Era permesso credere nei nostri sogni…
[]Je publie ci-dessous ma contribution à l’ouvrage collectif « Ben venga maggio, a cinquant’anni dallo sciopero al liceo di Lugano del 1974″ à paraître sous peu.
Qui di seguito, il mio contributo alla pubblicazione collettiva « Ben venga maggio, a cinquant’anni dallo sciopero del Liceo di Lugano » che uscirà di stampa tra poche settimane.]
Era permesso credere nei nostri sogni…
Paolo Gilardi
Al di là del prendere la misura del tempo che passa, evocare la nostra lotta al Liceo di Lugano nel 1974, dovrebbe, prima di tutto, essere l’occasione di rimettere in prospettiva quel movimento nel quadro del mondo di allora. Ma dovrebbe anche fungere da stimolo alla riflessione sulla situazione drammatica di quello del giorno d’oggi. È quanto cercherò di fare, in queste paginette.
Domandare la Luna?
Contrariamente alla licenza di condurre o alla patente di pesca, non vi era alcuna autorità che potesse accordarci il permesso di sognare: ce lo dava la realtà stessa nella quale, noi liceali, vivevamo il passaggio all’età adulta. Era una realtà, quella dell’inizio degli anni Settanta, che autorizzava la molteplicità dei possibili. In primis, perché vivevamo allora in un mondo che si diceva bipolare. Un mondo, cioè, nel quale il capitalismo, che fosse di stampo nord-americano o renano, non era il solo modo di organizzare le società umane. Anzi!
A quell’epoca, più di due miliardi di esseri umani vivevano in un sistema diverso da quello capitalista. Dalla Cina di Mao all’Unione sovietica di Krusciov prima e di Brežnev poi, passando dalla Cuba di Fidel Castro, esistevano forme differenti di organizzazione della società. Che non fossero ideali ed auspicabili era noto ai più; tuttavia, non foss’altro perché esistevano su larga scala, significava che quello in cui vivevamo non era il solo possibile.
La guerra fredda e la concorrenza tra i due massimi sistemi – per farla breve, tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica – imponeva di prendere posizione: stare con l’uno o con l’altro era quasi un obbligo. Ripensandoci oggi, l’ingiunzione di schierarsi in favore di un tipo di società non era poi cosa da poco! Sottintendeva l’evidenza di una pluraliltà dei possibili. Ed il posizionamento diventava anche molto sottile se si pensa che, all’interno di quei due sistemi, delle mobilitazioni sociali – penso alla cosiddetta “primavera di Praga”, alla rivolta degli operai di Stettino e Danzica nel 1970-71 così come al Maggio parigino, all’offensiva del Têt in Vietnam, alla rivolta studentesca in Messico o all’autunno caldo del 1969 in Italia – avevano messo all’ordine del giorno, se non proprio delle alternative, perlomeno dei correttivi.
Il dominio dei possibili era tanto ampio che persino l’impossibile diventava pensabile: non era ormai nemmeno più irrealista chiedere la Luna, visto che, il 20 luglio del 1969, due astronauti erano andati a farci due passi.
Cambiare la faccia del mondo
Gli anni Sessanta del secolo scorso consacrano – eccezion fatta per l’impero portoghese –l’accesso all’indipendenza delle antiche colonie africane. Nomi di personaggi quali Gabal el Nasser, Ahmed Ben Bella, Ouari Boumedienne, Patrice Lumumba, Moïse Ciombé, quasi quotidianamente citati nei radiogiornali, popolavano il nostro immaginario, anche perché, allora, al “notiziario” della radio non ci si scappava. Ed al di là dell’apparizione di nuovi paesi, le tensioni e conflitti tra questi personaggi e le forze da loro rappresentate esprimevano il fatto che, anche in quell’ambito, diverse opzioni erano all’ordine del giorno. In fin dei conti, se in poco più di un decennio si era cambiata la carta del mondo, era lecito credere di poterne cambiare anche la faccia.
La comprensione della capacità di movimenti sociali, massicci, di cambiare realtà che sembravano immutabili, eterne, era molto diffusa fra le giovani generazioni. Ed era pure alimentata dall’esperienza di una rivoluzione, quella cubana, che si diceva fatta a ritmo di salsa, e dalla rivoluzione culturale cinese di cui, di fatto, chi scandiva per le nostre strade “Mao-Lin Piao-Chen Pò Tà!” non aveva capito granché.
Questa consapevolezza, a volte implicita, della possibilità di rovesciare il corso della storia – cosa che si era già realizzata un paio di decenni prima con la sconfitta del nazi-fascismo – influenzò moltissimo la generazione dei cosiddetti baby boomer, la nostra. Numericamente molto importanti, noi giovani degli anni 1960-70 imponevano nuovi codici in materia di abbigliamento, di musica, di cultura e controcultura ed avevamo una fiducia certa nell’avvenire. Se per il teenager dell’inizio del ventesimo secolo, una delle prospettive possibili (ed anche assai probabile) era di diventare carne da cannone nelle trincee, la crescita economica senza precedenti dei cosiddetti Trenta gloriosi dava a noi giovani degli anni Sessanta ben altre prospettive.
Società dei consumi?
È giusto, ma oggi anche segno di un certo conformismo, vituperare il consumismo di cui erano impregnate le classi popolari di allora. E furono anche tanti, negli anni attorno al Sessantotto, a criticare quell’ingiunzione alla crescita, al consumo sfrenato.
Le società occidentali erano consumiste, poco sensibili alle problematiche culturali, ambientali, solidali: su questo non ci piove. Sarebbe però errato fermarsi solo sulla foto istantanea di quel momento senza misurarne le implicazioni nella loro evoluzione. Per la prima volta nel XX secolo, e non parliamo di quelli che l’hanno preceduto, le classi popolari conoscevano allora un accesso a forme di benessere inimmaginabili solo un quarto di secolo prima. A titolo di esempio, mio nonno a lavorare ci andava in bicicletta e ci è andato fino a settantacinque anni: in bicicletta ed anche a lavorare. Mio padre ci è andato invece prima con la Lambretta, poi con la “Millecento”…
Il miglioramento sostanziale – non è il caso in questa sede di analizzarne le cause – delle condizioni di vita delle classi popolari era un fatto che, di nuovo, dava la misura delle possibilità di cambiare la realtà. Il nostro accesso massiccio agli studi liceali – ne riparleremo – era parte di questi cambiamenti. Si era allora imposta la convinzione di un futuro sempre migliore che solo l’affermazione del neoliberismo negli anni Ottanta e Novanta verrà prima a scalfire, poi a sconvolgere.
Un passo enorme per l’umanità
La fede nell’avvenire, nella capacità di immaginare nuove forme di organizzazione della vita e della società, beneficia di un fatto nuovo, deterrente ed assolutamente unico nella storia degli esseri umani, in primo luogo delle donne. È in effetti il 9 maggio 1960 che la Food&Drug Administration statunitense autorizza la vendita in farmacia del primo contraccettivo orale. Negli anni seguenti, il fenomeno si generalizzerà a moltissimi altri paesi sino alla legalizzazione tardiva in Francia ed in Italia nel 1967. Più di quello di Amstrong sulla Luna, il passo è enorme per l’umanità: per la prima volta nella sua storia, grazie alla pillola contraccettiva, la sessualità, in primis quella delle donne, può essere dissociata dalla procreazione.
La portata è enorme: non solo mette in larga parte fine a secoli di pericolosi aborti clandestini praticati dalle “mammane”; ma induce nuove maniere di concepire la vita sessuale, la coppia, i rapporti uomo-donna così come stimola nuove aspirazioni. In particolare, quella ad una vita sessuale liberata, non foss’altro perché sottratta ai “sacri vincoli del matrimonio”, trascende i generi per diventare l’aspirazione di ampi strati giovanili. E rafforza il sentimento di potere, inteso nell’accezione primaria del verbo, cioè di facoltà di fare secondo la propria volontà.
Ascensore sociale
Si diceva prima che l’accesso al Liceo era a sua volta l’espressione di profonde modifiche, non tanto nella struttura sociale quanto delle rappresentazioni comuni. Non c’è ombra di dubbio: dieci anni prima, noi, figli di ferrovieri, impiegati postali, artigiani e piccoli indipendenti, in quel Liceo non ci saremmo mai entrati. Ma che idea! Ora, invece, facevamo parte di una élite, o perlomeno questa era la rappresentazione che se ne faceva.
Mi sia di nuovo permesso un riferimento personale: mio nonno fece il manovale durante tutta la sua vita lavorativa e – per colpa di un numero ridotto di annualità AVS – in pensione ci andò a 75 anni. Mio padre, dopo aver fatto un tirocinio coronato da successo, era entrato alle FFS, prima come operaio sino a diventare capo-reparto. Per me, il rampollo, vi fu la possibilità di andare al Liceo, cioè di seguire un corso di studi che non ti dava alcun tipo di formazione professionale e sboccava inesorabilmente in altri lunghi anni di formazione.
La “democratizzazione” degli studi era passata di lì. L’accesso di massa a formazioni di livello secondario superiore è stato voluto in Svizzera, così come in tutta l’Europa occidentale, per soddisfare i bisogni di una manodopera con alte capacità scientifiche e tecniche così come per sfornare, tra l’altro, gli insegnanti che avrebbero garantito la scolarizzazione delle centinaia di migliaia di bimbi che nascevano allora.
Però, quella scuola sino ad allora destinata alla riproduzione delle élite, non si era aggiornata, restava una scuola arcaica nella quale i valori che ci erano insegnati entravano spesso in conflitto con la realtà sociale e politica, tanto locale che internazionale. Ed anche in termini pedagogici, l’aggiornamento non c’era stato: a riprova, il mantenimento di un severissimo e quasi militare controllo delle assenze che darà poi fuoco alle polveri, nel marzo del 1974.
C’è però da dire che, paradossalmente, l’irreggimentazione dei liceali non era mal vista dai nostri genitori. Per due evidenti ed ovvie ragioni.
La prima, perché per loro, malgrado il discorso ufficiale sulla democratizzazione degli studi, il fatto di mandarci al Ginnasio e poi al Liceo rappresentava un notevole sforzo economico: dalla prima Ginnasio in poi, il materiale scolastico lo pagavano loro, non ci era distribuito dalla scuola. Ancora ho nella biblioteca personale, come un reperto storico, “il Mauger” (Gaston Mauger, Langue et civilisation françaises), così come il dizionario di latino che, col babbo, eravamo andati a comprare in Italia perché lì costava meno.
E poi, c’erano le spese per i trasporti, l’abbonamento del treno – meno oneroso per noi figli di ferrovieri – per la mensa e, per chi veniva da troppo lontano, quelle consentite per la camera alla Casa dello studente. Quindi, per i nostri genitori il controllo delle assenze era misura rassicurante, per evitare che, teste matte, preferissimo andare al cinema piuttosto che in classe.
Una seconda ragione stava nel fatto che il Liceo per loro era pur sempre realtà astratta. Non essendoci mai andati, quella scuola, quell’istituzione non la conoscevano, non sapevano veramente cosa fosse. Quindi il rispetto ossequioso dell’autorità – tanto praticato dai più umili –, nel nostro caso dell’autorità scolastica, era assai diffuso.
Un contesto politico nuovo
L’insofferenza dei liceali nei confronti di quella scuola arcaica, sia in termini di contenuti che di pratiche pedagogiche, trovava di che nutrirsi nel contesto politico della fine degli anni Sessanta et dell’inizio dei Settanta.
L’apparizione su scala internazionale di quella che tanti chiamarono la “nuova sinistra” aveva trovato riscontri in Ticino. Nel 1969 nasceva da una scissione nel Partito socialista, partito di governo, il Partito socialista autonomo, il PSA. Nel linguaggio comune, chi usciva dal consenso veniva sistematicamente tassato di “PSA”. “Cuel lì, l’è un piessaa”, si diceva nelle osterie di chi aveva magari dei comportamenti poco ortodossi o anche solo i capelli un po’ lunghi. Ma di fatto, la vox populi dava al malcontento dei giovani un’etichetta – che fungeva da identificazione – situata chiaramente a sinistra della sinistra.
La vicinanza con l’Italia si faceva anche sentire con l’esistenza di organizzazioni della nuova sinistra molto attive e che disponevano anche di contatti in Ticino, in particolare Avanguardia operaia. Eppoi, addirittura un ramo ticinese della Lega Marxista Rivoluzionaria, la sezione svizzera della Quarta Internazionale, era stato fondato nel 1973: vi aderimmo subito in due, Donato Mottini ed io, prima di essere raggiunti da altri, in particolare Rolando Schärer. Dei nipotini del primo presidente del Soviet di Pietroburgo, dell’artefice dell’insurrezione di Ottobre sui banchi del Liceo di Lugano: L’image est saisissante, direbbero i Francesi!
In un contesto in cui si erano prodotti dei movimenti sociali quali le manifestazioni giovanili per un centro autonomo autogestito o lo sciopero delle operaie della ditta Savoy, la scuola non restava impermeabile nella sua torre d’avorio. Era così nata nel 1969, in seno all’Associazione cantonale dei docenti socialisti, la rivista «Verifiche», che postulava nuove pratiche pedagogiche antiautoritarie e contenuti perlomeno “spolverati”. L’istituzione, comunque, si premuniva contro tali aspirazioni come attesta il Libro bianco della repressione nella scuola ticinese pubblicato all’inizio del 1972[1].
Queste dimensioni politiche erano molto diffuse fra i liceali anche perché, a quell’epoca, di canali televisivi ce n’erano pochi e la televisione aveva fatto la sua entrata praticamente in tutte le case. Difficile quindi sfuggire ai dibattiti politici della sera prima di cui discutevamo poi l’indomani ed alle immagini dei B52 che annaffiavano di napalm le risaie del Vietnam…
Figuriamoci se ci sfuggirono quelle del colpo di stato perpetrato da Pinochet in Cile l’undici settembre, quattro giorni esatti prima dell’inizio di quell’anno 1973/74!
Cosa ci siamo portati a casa?
Fu questo il contesto nel quale maturarono quei due bellissimi mesi di lotta al liceo. Un’esperienza che permane, in misure diverse, nell’essere di quella nostra generazione. Perché, se gli studi liceali ti portano alla “maturità”, quei due mesi furono parte costitutiva, alla pari dei metodi di studio e delle materie imparate, della nostra maturità. Uscimmo da quell’esperienza, per l’appunto, più maturi, formati al dibattito democratico sperimentato nelle assemblee, alla lettura delle realtà sociali, alla comprensione dei rapporti di forza, con un sentimento di potere. Ben prima del celebre Yes, we can! di Barak Obama, noi l’avevamo fatto. Fu l’origine per molti di noi, di un duraturo impegno in ambito politico, sociale, giornalistico, per non citare che questi.
Cinquant’anni dopo, in un mondo che sembra dar ragione a chi, già dagli anni Ottanta aveva, mi si perdoni l’ossimoro, predetto il no future, restare fedeli a quell’esperienza fondatrice è vitale.
Per un altro possibile
L’implosione della Russia sovietica e la svolta cinese verso il capitalismo militarizzato hanno dato credito all’arrogante pretesa della Signora Thatcher secondo la quale There is not alternative, cioè non ci sono alternative, sottinteso, al capitalismo. Su un altro piano, la riproduzione, da parte delle nuove classi dirigenti dei paesi liberatesi dal giogo coloniale, dei funzionamenti odiosi che furono quelli degli antichi coloni diede colpi terribili alla credenza nella purezza delle rivolte nel Terzo Mondo.
L’emergenza di una disoccupazione strutturale, la mancanza di sbocchi per i laureati, la precarizzazione di milioni di giovani hanno distrutto le basi di quel sentimento di sicurezza che era quello della nostra generazione. La sconfitta storica del movimento operaio di fronte all’offensiva neoliberista l’ha anche privato della sua attrattività presso le giovani generazioni; quanto alla liberazione sessuale, l’AIDS ne ha drammaticamente definito i limiti.
Il campo dei possibili si è così ridotto ad un solo possibile: saremmo, né più né meno, secondo Francis Fukuyama, (al)la fine della Storia. I risultati dell’avvenire radioso profetizzati nel 1992 da questo universitario statunitense saltano oggi agli occhi. Non è il caso qui di procedere ad un elenco dei mali che affliggono il nostro mondo e che lo minacciano.
Mali e minacce – compresa quella, terrificante, di una guerra atomica tornata ad essere pensabile – ci impongono, nella continuità della primavera del 1974, di contribuire con le nuove generazioni a reinventare dei possibili, primo fra i quali quello di un altro mondo.
Prima di finirci noi, all’altro mondo…
[1] •••